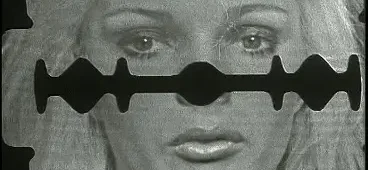Per Alessandro
di Daniela Turco
A pochi giorni dalla sua scomparsa, mentre ancora domina il senso di perdita e di vuoto, è veramente difficile per me scrivere di Alessandro Cappabianca, come è difficile ritornare indietro con la mente agli anni ormai lontani in cui la sua presenza insieme a quella di Edoardo Bruno rendeva unica, solida e speciale la rivista (ad Alessandro, che si schermiva, allora ripetevo spesso che lui era “la pietra angolare” di Filmcritica). Oggi, mentre sto scrivendo, cercando di non lasciarmi travolgere troppo dalla malinconia, mi sembra impossibile anche solo provare a restituire qualcosa di ciò che Alessandro ha rappresentato per Filmcritica, per molti di noi, per me, dire che cosa significava nelle riunioni di allora, nella mitica redazione di piazza del Grillo, potersi confrontare con il suo pensiero critico e con le sue parole, talmente alta era la considerazione che avevamo per lui…
Alessandro era una persona rara, che non si imponeva, per carattere era estremamente schivo, aveva una timidezza che lo portava più al silenzio che alle parole, poi, però, quando iniziava a parlare, succedeva un po’ come in certi racconti fantastici di Hoffmann, quando all’improvviso si apre una porta segreta che ti porta altrove rispetto a quello che avevi creduto di vedere, ascoltare, o perfino conoscere, nel senso che le sue osservazioni riuscivano sempre a liberare una visione molto più profonda e autentica, attraverso l’esercizio di un’altra prospettiva; il suo, era sempre un punto di vista radicalmente differente.
Posso dire che per me la frequentazione con Alessandro è stata a tutti gli effetti una scuola – molto libera, senza cattedre – un vero incontro tra un maestro e un’ allieva, con una continua possibilità di confronto sui saperi – , e condividere per molti anni con lui le visioni ai festival, le discussioni sui film, le rassegne, i convegni in cui come rivista eravamo spesso impegnati, dove i suoi interventi erano sempre illuminanti su ciò che è essenziale, è stato nello stesso tempo un privilegio e un tirocinio reale nel quale non si poteva che imparare, tutti noi catturati dal dono innato che aveva nel leggere e comprendere i segni del cinema, e non del cinema soltanto…
Quando nel 1996 uscì il libro di Fabio Segatori L’avventura estetica, dedicato ai primi quarantacinque anni di Filmcritica, uno dei paragrafi si intitolava “Lo spazio cinematografico di Alessandro Cappabianca”, segnando il suo ingresso nella rivista, con cui, salvo una breve parentesi, avrebbe continuato a collaborare dal 1969 fino a pochi mesi fa, quando la sua vista era talmente peggiorata da impedirgli definitivamente di scrivere…
Sottolineare fin da subito lo “spazio cinematografico” di Alessandro Cappabianca significava proporre il profilo di un critico, fortemente cinefilo, senza dimenticare la sua formazione di architetto, che era infatti destinata a lasciare una traccia persistente nella sua scrittura e a orientare i suoi campi di interesse. Alessandro aveva iniziato la collaborazione con Filmcritica poco più che trentenne, per occuparsi, secondo le parole di Segatori “di immagine e tempo”: [1] ”Il cinema, nell’analisi di Cappabianca, è definito come luogo del possibile, spazio di una compresenza di più temporalità, di diverse percezioni temporali (ricordo, immaginazione, sogno, “realtà”, ecc.) slegato dal canonico e tradizionale concetto del racconto come “già avvenuto”. [2]
Nei lunghi anni del suo percorso dentro Filmcritica il suo lavoro critico, sottile, analitico, intensamente teorico, ma sempre sostenuto anche da un approccio militante che si misurava direttamente con i film e con le uscite in sala, Alessandro si sarebbe preso tutto il tempo necessario per esplorare con i suoi testi tutti gli aspetti essenziali del cinema che lo coinvolgevano di più: il tempo e le diverse temporalità all’interno del film, la materialità illusoria dei corpi, le ombre, lo spazio sempre misterioso del set, il racconto e la sua eclisse, il sogno, la dimensione fantasmatica e quella psicoanalitica, trovando di volta in volta nei registi da lui prediletti, su cui ha scritto delle monografie memorabili, tra cui Billy Wilder, Eric von Stroheim, Antonin Artaud, Carmelo Bene, Roman Polanski ecc., altrettanti soggetti singolari e fortemente anomali, con cui stabilire un rapporto che si trasformava poi nel cristallo trasparente e sfaccettato della sua scrittura, lo spazio a molte dimensioni dove si tracciava l’immagine mutante e in divenire della sua ricerca teorica.
Tra i suoi libri, vanno almeno ricordati: La costruzione del labirinto. La scena, la maschera, il gesto, la cerimonia (1974), Distruggere l’architettura (1979), Ombre urbane (1982), Il cinema e il sacro (1998), Boxare con l’ombra. Cinema e pugilato (2004), L’immagine estrema. Cinema e pratiche della crudeltà (2005), Fantasmi dell’abitare. La casa e l’immaginario: film, scrittura, architettura (2011), Trame del fantastico. Riflessi e sogni nel cinema (2011), Alla ricerca del corpo perduto. Perversione e metamorfosi del cinema (2012), Ontologia del corpo nel cinema comico(2014), ecc.
Ma è stato soprattutto attraverso i suoi ultimi testi tra cui Metamorfosi dei corpi mutanti. Il divenire-altro delle creature cinematografiche (Timìa, 2016) e La parata dei fantasmi (Accademia University Press, 2018), che Alessandro ha potuto nuovamente esplorare la domanda “Che cos’è il cinema?”, che stava al cuore del libro-guida di Andrè Bazin, pubblicato in Francia nel 1958, rilanciandola in piena rivoluzione digitale, per metterla in tensione in un modo innovativo e molto produttivo con la ricchezza di un pensiero filosofico e letterario che spaziando da Derrida a Deleuze, da Klossowski a Kafka ad Artaud, conferisce ai suoi testi profondità e spessore teorico. E’ soprattutto la “parata dei fantasmi” di cui si è a lungo occupato Jacques Derrida, a interessare Alessandro, che pur vedendo sostanzialmente il cinema come un dispositivo “di conservazione di tracce corporali di corpi scomparsi”, fantasmi condannati a ripetere gli stessi gesti, crede tuttavia alla potenza delle metamorfosi, alla forza irresistibile di un divenire che sta alla base del cinema: restare identico, eppure diventare altro; questa la definizione profonda con cui Cappabianca provando a rispondere alla domanda “che cos’è il cinema”, mette a fuoco quelle linee sottili che “variano la struttura dell’immagine per portarla nei territori del fantastico e del virtuale”.
Invece, apparentemente scartato dal campo della teoria e della critica cinematografica, è importante segnalare l’unico – credo – libro di fiction di Alessandro: Urlare. Si fa presto a dire matti (Timìa, 2022), un romanzo breve che si accorda con l’antagonismo poetico e politico del suo pensiero, e si muove nella linea novecentesca della dissoluzione del soggetto, convocando Dostoevskjj, Pirandello, Artaud, Nabokov, Bene – in chiaro – mentre nell’ombra del testo si nascondono altre presenze fantasmatiche, Gadda, Kafka, Jaeggy, Bulgakov, ecc…
Un libro estremo, diverso, sorprendente, dedicato alla moglie Maria, che riunisce un esercizio di lucida, programmata follia, dove si inseguono struttura e distruzione, eclisse e progressiva, metodica cancellazione della stessa nozione di autore.
Alessandro riusciva anche a ritagliarsi sempre uno spazio per le incursioni nei libri degli amici: ne sono esempi recenti la collaborazione con Ilaria Gatti, sua carissima amica, per Chantal Akerman. Uno schermo nel deserto (Fefè, 2019) e la prefazione al libro di Mariuccia Ciotta e Roberto Silvestri, Spettri di Clint. L’America del mito nell’opera di Eastwood (Baldini+Castoldi, 2023), due amici che Alessandro ammirava, da loro ricambiato, in quanto, come lui, esploratori sensibili dell’immaginario cinematografico, con cui avevano trasformato le pagine del quotidiano Il Manifesto in anni ora lontani in un laboratorio permanente di visioni.
Negli anni condivisi a Filmcritica Alessandro, veniva spesso, scherzosamente, chiamato Cappa da Edoardo Bruno, e ricordo più di un’occasione in cui Lorenzo (Esposito) e io discutevamo insieme di un misterioso “fattore Kappa”, nel senso di un segreto nascosto nella scrittura di Alessandro Cappabianca che affascinava entrambi e ci faceva pensare. Che poi il “fattore K” ci richiamasse inconsapevolmente a Kafka, e all’enigma di quell’altra scrittura, è possibile, ma credo comunque che fossimo entrambi convinti che il modo del tutto speciale di scrivere di Alessandro costituiva in sé una parte essenziale della sua ricerca, e che quel nucleo che poteva sembrare solo a una lettura superficiale il racconto del film, da cui spesso Alessandro partiva nei suoi testi per Filmcritica, nascondeva in realtà un dedalo di linee nascoste, che guidavano il lettore verso altri labirinti in cui perdersi.
Questa passione profonda, questo “vizio” come lui stesso a volte lo definiva, questa magnifica ossessione di Alessandro per la scrittura, che – ed era questo uno dei suoi tratti più stupefacenti – non era mai ripetitiva, ma semmai rinnovava e ampliava continuamente con un andamento spiraliforme la sfera della sua ricerca, a partire dal gennaio 1994 trovò la forma di una rubrica fissa: “Visioni” che da allora fino al gennaio 2019[3], avrebbe concluso ogni numero Filmcritica, condividendo spesso le ultime pagine insieme a “Il corto”, l’altra rubrica fissa dell’amico Sergio Arecco, con cui Alessandro aveva vissuto dentro la rivista l’irripetibile stagione degli anni ’70, segnati da teoria, politica, linguaggio, sperimentazione critica.
Ho sempre pensato che per Alessandro “Visioni”, che, per inciso, erano la prima cosa che leggevo in ogni numero insieme all’editoriale di Edoardo, quelle due, tre pagine scarne, alla fine della rivista, fossero immaginate da lui precisamente in termini spaziali, come un segno dell’architetto che continuava a essere, una specie di studio/stanza personale, solamente suo, dentro Filmcritica.
E se la ricchezza inesauribile della sua ricerca teorica lo portava naturalmente a scrivere molto, e a produrre molti libri e testi, collaborando con molte testate diverse – Alessandro in questo era tanto libero quanto generoso -, tra cui “Casabella”, “La città di Riga. Rivista d’arte”, “Fata Morgana”, “La Corte”, “Spirali”, “La furia umana”, “UZAK”, “Il Manifesto” ecc,, sulle cui pagine si sono affollati in questi giorni di lutto molti ricordi, partecipati, commossi, di Alessandro, non credo che ci possano essere dubbi sul fatto che considerava Filmcritica come la “sua” rivista di elezione. Per questo non posso che essergli più che mai grata per essere sempre stato vicino alla rivista e a noi, soprattutto negli anni più difficili, dopo la morte di Edoardo Bruno nel 2020, con la fine dei fascicoli cartacei, e con il passaggio definitivo al sito online. Alessandro con la naturalezza che gli era propria aveva collaborato fin da subito con il sito, continuando a mandare i suoi splendidi pezzi finché ha potuto, nonostante i problemi molto seri di udito e di vista che aveva. Questa vicinanza, questo affetto per Filmcritica, e per noi, questa generosità che lui ci ha dimostrato, per me è senza prezzo, e posso solo ringraziarlo per questo, ancora una volta, per l’ultima volta, a nome di tutti, caro, carissimo Alessandro…
[1] Cfr F. Segatori, L’avventura estetica. Filmcritica 1950-1995, Il Saggiatore, Milano 1996, p. 130-131
[2] Ibidem
[3] Nel n° 691 di Filmcritica compare per l’ultima volta la sua rubrica “Visioni”, anche se Alessandro ha comunque continuato in seguito a scrivere per la rivista.