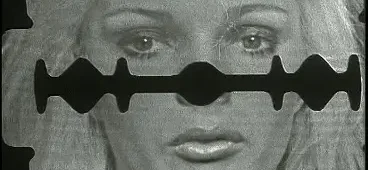Per Alessandro Cappabianca
di Sergio Arecco
Alessandro era un architetto. Lo conobbi a Venezia, alla Mostra del 1970. Vedemmo tutti i film insieme, condividendo fin d’allora, in toto, predilezioni e rifiuti (ricordo che stroncammo, seduta stante, I clowns di Fellini, bozzettistico, e Uomini contro di Rosi, a proposito del quale Alessandro, lui così ritroso e refrattario alla scena, chiese addirittura la parola per rimproverare al regista la retorica delle “morti in primo piano”, spiazzandolo completamente). Fu alla fine del Festival che mi disse: “Non torno a Roma. Da Venezia, già che ci sono, proseguo per Vienna. Mi accompagna mia sorella. Voglio vedere gli edifici di Adolf Loos, capire come mai si sia schierato, dopo avervi in qualche modo aderito, contro la Secession. Penso per contestarne decorativismo e calligrafismo”. Ne convenni (io avrei visitato e studiato Vienna un po’ più avanti; lui, per età, mi precedeva di otto anni). Alessandro era uno speculativo, un architetto adepto del rigore e della razionalità (proveniva dalla rivista del settore Casabella, lavorava non per il privato ma per il pubblico). Riecheggiavano, in quelle parole, i medesimi principi, etici ed estetici, che adottava quando si cimentava con la scrittura: elegante, raffinata, coltissima, ma anche, per così dire, geometrica, ispirata non solo all’emozione dello sguardo ma anche e soprattutto alla concettualizzazione/costellazione del giudizio.
Erano gli anni della linguistica e dello strutturalismo, delle tecniche e delle nomenclature. Alessandro naturalmente, come me, come tutti noi, vi attingeva, ma con misura, con temperanza, badando sempre a equilibrare concreto e astratto. Eravamo davvero complementari in seno a Filmcritica. Forse Edoardo Bruno, con la sua inarrivabile intuizione, ci aveva messo uno accanto all’altro (fummo “coppia fissa” fino ai primi anni Novanta) per ottenere due portati diversi e al tempo stesso convergenti: quello più analitico/sintetico e quello più emotivo (il mio, specifico di un cinefilo forte innanzitutto di un’educazione letteraria e musicale). Funzionammo alla perfezione. Alessandro introdusse in Filmcritica la teoria (con Ciriaco Tiso, anche lui presente in quegli anni): insieme composero a quattro mani un numero speciale, non firmato, totalmente libero, un manifesto militante, di una sessantina di pagine, sulla semantica del film, sulla sua cifra linguistica, sulla sua risonanza estetica ad ampio raggio: il battesimo del binomio aggettivale poetico-politico, correlato all’idea del “senso in più” di Edoardo, si ebbe in quell’occasione. Io introdussi l’extravagante, l’eccentrico, l’insolito, l’arbitrario di De Saussure; contrapposi l’indisciplina alla disciplina, il lirico allo strutturale. Incline, in ciò, a condividere, ancora una volta, una delle passioni di Alessandro, quella per Antonin Artaud, sul quale egli scrisse due saggi straordinari (il primo per l’Epos, coraggiosa casa editrice palermitana, oggi ovviamente scomparsa, presso la quale m’introdusse). Laddove, tuttavia, contro la mia tendenza all’immedesimazione con il personaggio, sviluppò a pieno regime la sua tendenza alla critica dei materiali. Tiso seguì poi un suo curriculum televisivo, che ahimè si concluse troppo presto. Alessandro, per parte sua, rimase abbarbicato alla rivista come ”rivista di tendenza”, alternativa al dettato dominante, arricchendola con contributi destinati a restare nella mente e nello scrigno di conoscenze del lettore, dal saggio su Totò, uno dei suoi primi, alla rubrica a tutto campo “Lo spettatore critico”.
Erano anche gli anni dell’avvento della collana “Il Castoro”, alla quale Alessandro approdò prima di me con due autori diversissimi, Billy Wilder (1976) e Erich von Stroheim (1979), a testimonianza della versatilità dei suoi interessi, della metodicità e insieme della flessibilità di una linea ermeneutica ad amplissima gittata, applicabile, grazie a duttilità e congruenza (un termine che piaceva molto ad Alessandro) intellettuale a qualsiasi genere e a qualsiasi stilema cinematografico – una linea, ancora una volta, complementarmente, per me condivisibile appieno: io saltai da un Angelopoulos (1977) a un Ôshima (1978), che scoprimmo assieme a Pesaro, a un Cassavetes (1979). Anche se, dopo quei favolosi, non solo per noi, anni Settanta, le nostre strade si divaricarono un po’. Io mi profusi molto con i Castori (cinque), lui scrisse tra l’altro Distruggere l’architettura per Serra & Riva, e continuò a sviluppare con l’acribia che gli conoscevamo i suoi studi di architettura e di filologia (e fisiologia) delle immagini. Non aveva un carattere facile, Alessandro, era dotato di un’innata bontà e generosità, ma era anche pervicacemente legato a una serie di connotazioni culturali tutte sue, non sempre di facile accesso e talvolta gelosamente custodite (vedi l’episodio del suo momentaneo distacco da Filmcritica per propiziare la fondazione di Fiction).
Fu il periodo, anche lungo, in cui ci si incontrava solo ai Festival, Venezia in primis (dormivamo negli stessi alberghi, un paio di volte persino nella stessa camera, condividevamo aperitivi e pasti, passeggiate al Lido ed esperienze: lui si era sposato con Maria, aveva due figli, e io, guarda caso, come lui, sposato con due figli), con la perenne, confermata a ogni giro di vite, corrispondenza di giudizi favorevoli o sfavorevoli, nonché di memorabili proiezioni per pochi – ricordo la serata in cui vedemmo per la prima volta, in una retrospettiva del New American Cinema, Me and My Brother di Peter Frank, e saltammo letteralmente sulla sedia, decidendo di dare d’acchito il nostro Oscar alla carriera al sottovalutato Christopher Walken, nume tutelare, a ben vedere, di gran parte del cinema par excellence dell’ultimo mezzo secolo. E in cui editorialmente, ci si incontrava nel catalogo della neonata casa editrice Le Mani, lui con libri di alto magistero, vuoi sulla boxe vuoi sul sacro (strepitoso quest’ultimo), io con monografie, credo puntuali, su Bergman, Bresson o Resnais. O sulle pagine di riviste come “Fata Morgana”. Se no, fisicamente, al Torino Film Festival nel suo periodo aureo o a rassegne e convegni. A “Ring”, per esempio, mitico festival alessandrino della critica cinematografica degli anni Novanta e Duemila, dove Alessandro venne invitato a tenere una lezione/ monologo su un tema a suo piacimento; e lui, per oltre mezz’ora, davanti a una platea stupefatta, divagò alla Derrida sul cinema come fantasma in sé e come magico latore della virtualità del fantasma (in serata, in sala grande, ci godemmo, seduti uno accanto all’altro, una performance di Ciprì e Maresco, al tempo, quello di Il ritorno di Cagliostro, al loro massimo livello di doppio creativo).
O, sempre fisicamente, a un convegno pavese sull’«Abitare la casa», in cui gli toccò di parlare, causa la prolissità dei precedenti intervenuti, giusto intorno alle 22, visibilmente seccato e disturbato (aveva già a che fare con la sordità), tanto che, per una sorta di rivalsa, ampliò in seguito il contenuto del suo intervento e ne fece un libro dei suoi, acuti, profondi, meditati, di indiscusso riferimento: Fantasmi dell’abitare. La casa e l’immaginario: film, scrittura, architettura (2011). Una summa, come si può ben rilevare dell’Alessandro-pensiero. Non manca nulla della filosofia di Alessandro – e pronuncio questa parola a chiare lettere: comprendendovi tutta la metafisica e tutta la densità che le sono intrinseche –: fantasma, immaginario, scrittura e architettura, matrice sovrana di ogni disegno mentale.